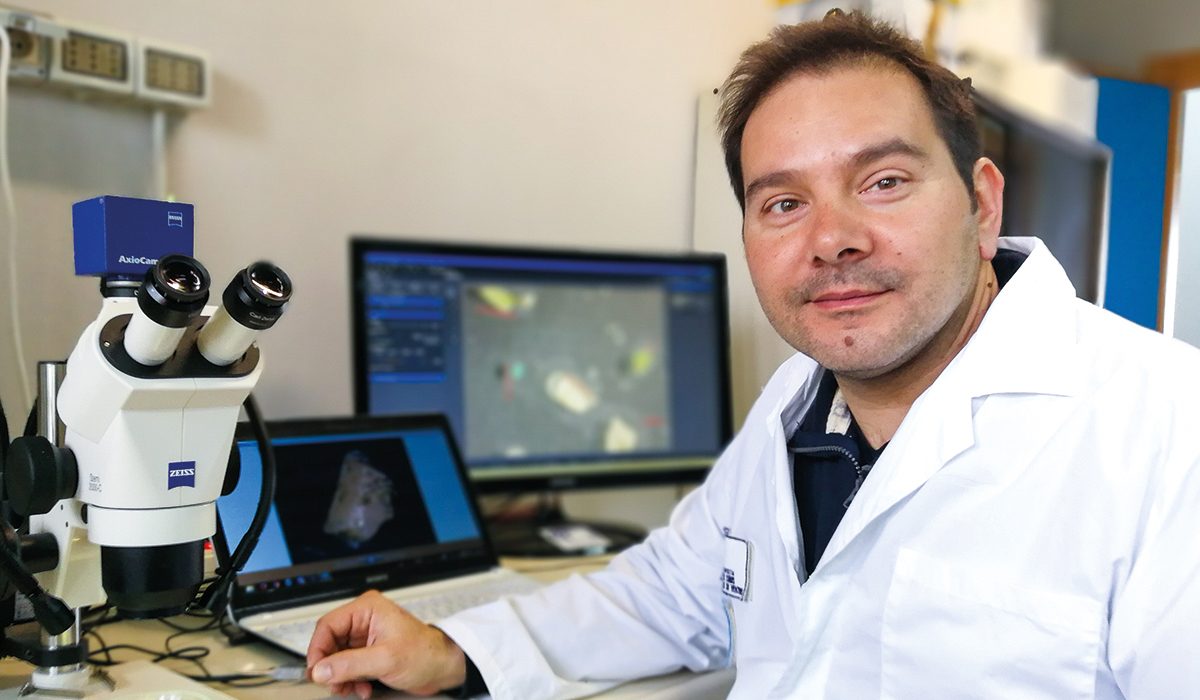Il luogo che voglio raccontare si trova sul fondo del nostro mare, a circa 50 metri di profondità nel Golfo degli Angeli, a largo di Capo Sant’Elia. Tuffandosi da quelle parti, oltre ad ammirare una candida distesa di sabbia che fa da letto alle acque più cristalline del mondo, si può incappare in uno dei numerosi relitti che popolano il Golfo di Cagliari: il rimorchiatore statunitense LT221 (Longer Tug), adibito alla posa di mine e allo sminamento. La classe LT fu costruita negli anni ‘41-’43 in diversi cantieri degli Stati Uniti; erano navi da supporto alle operazioni di manovra dei grandi cargo, ma poi furono utilizzate sui vari fronti delle battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale. Proprio per questo la LT221 ebbe vita breve: fu affondata nell’ottobre del 1944 in seguito all’urto con una mina.
Se ne erano perse le tracce da più di mezzo secolo quando, nei primi anni Novanta, noi “cercatori di relitti” la ritrovammo. Giaceva sul fondo del mare assieme a un’enorme mina ancora armata, che faceva coppia con quella che era esplosa e che l’aveva affondata. Tante vecchie reti erano impigliate nello scafo e una bloccava la porta della plancia di comando, ma dalle finestre si poteva scorgerne l’interno: la ruota del timone e il telegrafo di macchina erano ancora lì, come pure era lì la campana in bronzo di prua, l’anima della nave. C’era qualcosa di particolarmente familiare all’interno di quella plancia. Immergersi laggiù era come fare un viaggio nel tempo futuro di un’altra nave che conoscevo e che era ancora nel suo pieno splendore.
Altroché se la conoscevo. C’ero praticamente sopra da qualche anno! Si chiamava “Bannock” (dal nome di una tribù di Nativi Americani degli Shoshoni) e nel 1963, dopo essere stata affittata dagli Stati Uniti all’Italia, era stata messa a disposizione del Consiglio Nazionale di Ricerche che aveva provveduto, nei cantieri navali di Genova, a ristrutturarla in modo da farne una nave oceanografica. Poi, nel 1979, il governo l’aveva dismessa e l’Italia ne aveva acquisito la piena proprietà per il prezzo simbolico di 100 lire. Così la “Bannock” aveva proseguito a pieno titolo la sua gloriosa carriera di nave al servizio della scienza. Quando, con me a bordo, s’imbatté nella sfortunata gemella, era stata già utilizzata in numerose missioni di ricerca alle quali avevano partecipato grandi esperti di oceanografia, geologia e geofisica, biologia delle università italiane e straniere. Tra essi anche Jacques Cousteau.
Da parte mia, ci lavoravo da cinque anni – coinvolta nelle campagne di mappatura geofisica dei fondi marini – quando, nel 1991, la Bannock partì dal porto di Genova per la sua ultima crociera scientifica. A bordo avevo appreso i fatti del suo passato “guerriero”, sapevo che era nata nel 1942 e che nel 1944 era stata dislocata nei mari britannici, aveva partecipato alle operazioni preliminari dello sbarco degli alleati in Normandia. Era sopravvissuta ai numerosi raid aerei della Luftwaffe nelle settimane prima del D-day, l’assalto decisivo per la liberazione dell’Europa dal nazismo. Quindi, tornata nelle acque statunitensi rimorchiando l’incrociatore Nelson, aveva raggiunto Pearl Harbour ed era stata destinata a operazioni fra le isole Marianne e Guam, poi a Okinawa. Insignita di ben due “stelle di battaglia”, dopo la caduta del Giappone era rientrata in patria, era rimasta ferma per anni, fino alla sua nuova “vita italiana”.
Era malinconico immaginare, da bordo della Bannock, il relitto della sua gemella. Ed era inevitabile pensare alle tante volte in cui – dalla Normandia alle Marianne – aveva rischiato di seguire la stessa sorte. Invece le era andata bene. Sembrava la rappresentazione navale di quelle tante personalità che riuscirono, dopo la fine della guerra, a primeggiare nel tempo di pace. E ci ricordava che questo era stato reso possibile non solo dal talento (le LT erano tutte ottime navi), ma anche dalla fortuna. Un concetto che non dovremmo mai perdere di vista. Anche perché poi la fortuna gira. La Bannock da molti anni giace in stato di abbandono in un angolo del porto di Napoli.
Daniela Pani