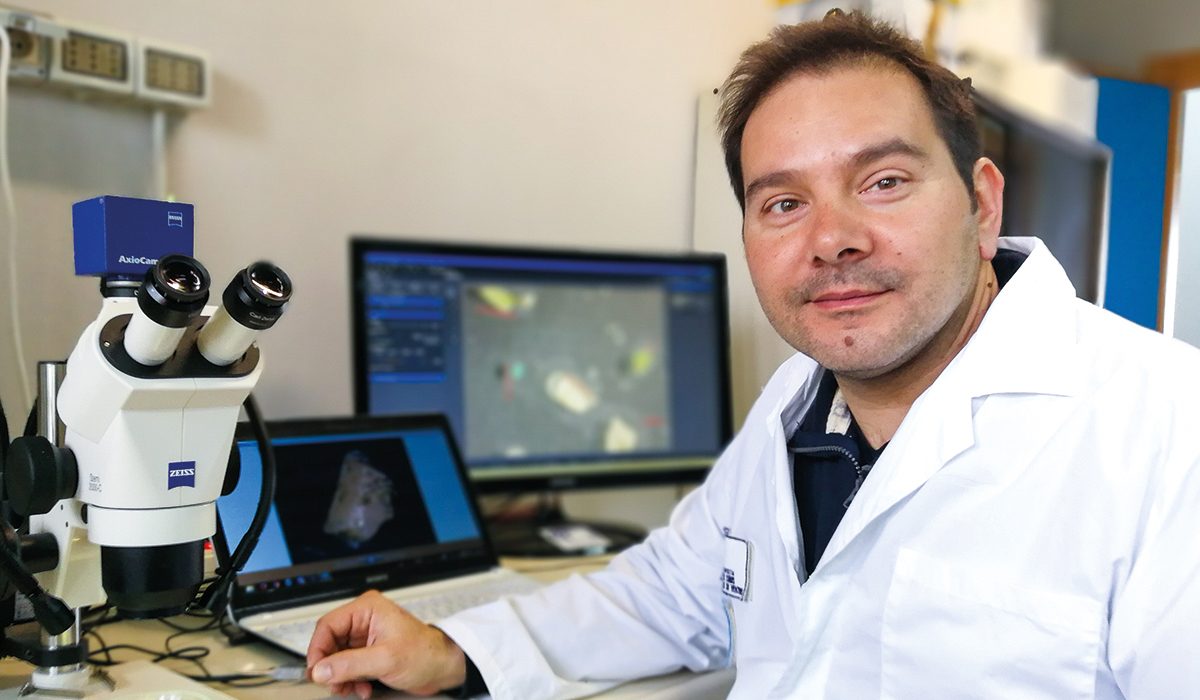Quando il 20 giugno 1668 don Augustìn Castelvì viene assassinato mentre rientra di notte nella sua casa di Castello, a Cagliari, si pensa che l’ordine sia venuto dal viceré in persona, Manuel de los Cobos, marchese di Camarasa. Augustìn Castelvì, signore poderoso ed esponente di primissimo piano della nobiltà sarda è infatti il capo riconosciuto di uno dei due grandi “partiti” – l’altro è quello degli Alagòn – in cui è divisa la nobiltà sarda. Pensa Castelvì che ai sardi – ai sardi nobili, s’intende – debba essere riservato il monopolio degli incarichi pubblici e che questa sia la condición a cui deve sottostare la Corona se vuole vedersi attribuito il “donativo”, la contribuzione periodica che la Sardegna le versa. Qualcosa il viceré – che parla a nome della Corona – concederebbe, ma sempre, inderogabilmente, “por via de sùplica”. Nulla di particolarmente eversivo, nulla che intacchi la sostanza del legame alla Corona. Così in Sardegna come in altre parti del Regno, il rapporto tra Madrid, e le élites provinciali è materia magmatica. “Gli atti di fedeltà e le profferte di servizio – ha scritto Francesco Manconi, l’indimenticato storico della Sardegna spagnola – si alternano a episodi di sedizione, a cui seguono sovente ricomposizioni, improvvise e strumentali”. Suona di certo sediziosa la campagna messa in piedi dai sostenitori di Castelvì, quando indicano nel viceré il committente dell’omicidio del loro capo. Con metodi modernissimi – il Seicento sorprende per quanto sa essere moderno – fanno di Castelvì un martire dell’idea. Difficile, però, definirla una “idea”. Capace di altezzosi atti di ribellione, Castelvì non rappresenta interessi che non siano quelli della cerchia di nobili che a lui fanno riferimento. La posta in gioco è il potere e quella modesta quota di gloria che può spettare a una nobiltà provinciale. Nulla a che fare, insomma, con quanto vorranno vedere nell’episodio i suoi volenterosi rivisitatori ottocenteschi. L’idea di Sardegna come patria deve ancora venire. È il 21 di luglio, un mese esatto dalla morte di Castelvì, e Castello di nuovo si macchia di sangue. A cadere nell’agguato è il marchese di Camarasa, abbattuto da due fucilate, mentre nel cocchio viceregio prende parte alla celebrazione della Madonna del Carmine. Gli sono stati risparmiati i fendenti di coltello che, dopo le fucilate, sono invece toccati a Castelvì. Il movente politico questa volta è indubbio. Oltre all’idea corrente che il viceré sia stato il mandante dell’assassinio di Castelvì, c’è il dissidio politico di fondo, in una stagione nella quale, non meno di oggi, la politica può generare odio. Camarasa, sin da quando è arrivato a Cagliari qualche anno prima, è stato individuato come il nemico della grande nobiltà locale. La nobiltà sarda, si dovrebbe dire, quando si tenga presente come quegli stessi nobili che hanno complottato contro Camarasa (e magari sono i responsabili della sua morte) rivendichino con orgoglio la parte che i loro non lontanissimi antenati hanno avuto nella conquista iberica dell’Isola. La conclusione della storia è forse sorprendente. Entra in scena l’amore, anche se si tratta di un amore omicida. Risulteranno essere la moglie di lui, Francisca Zatrillas, marchesa di Siete Fuentes, e il suo amante Sylvestre Aymerich, i mandanti dell’uccisione di Castelvì. Aiuta a capire il movente il fatto che Francisca sia la nipote di Castelvì e di vari decenni più giovane. Quanto all’uccisione di Camarasa, la matrice politica è confermata dall’inchiesta. Ma, “no haviendose perpetrado este delito con tumulto popolar”, non essendosi cioè l’aggravante del coinvolgimento del popolo nella faccenda, molti tra i partecipanti al complotto finiranno per passarla liscia.
Luciano Marrocu